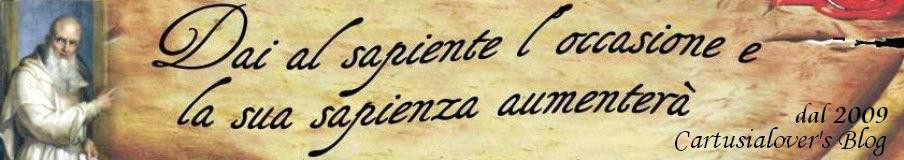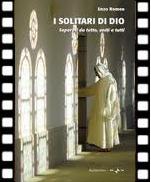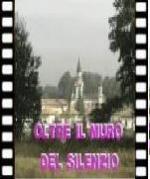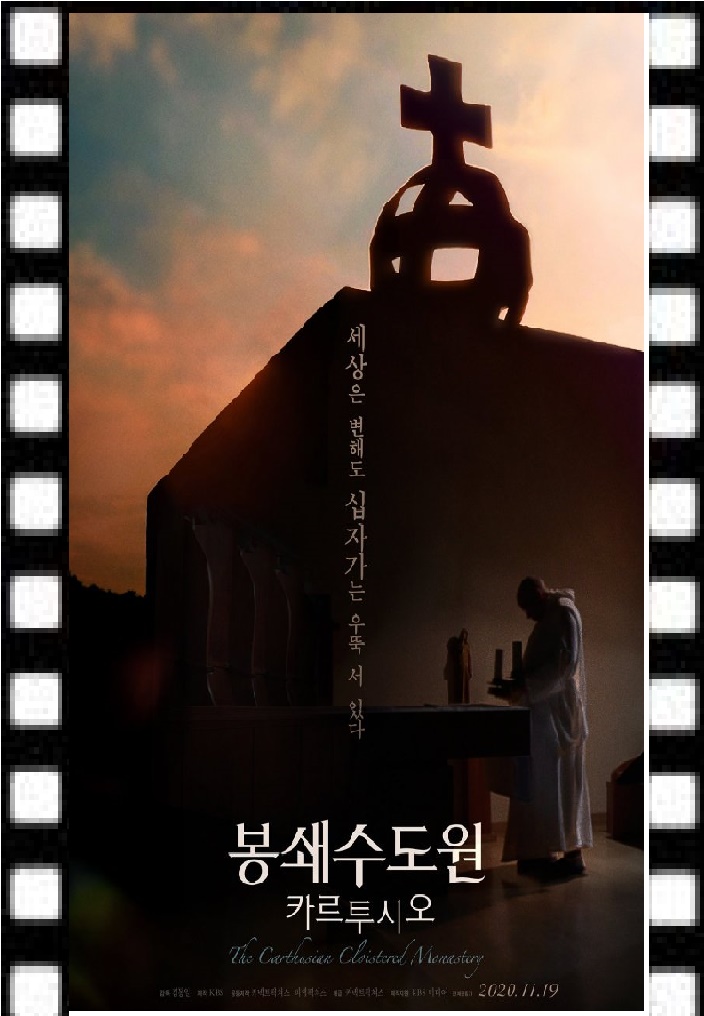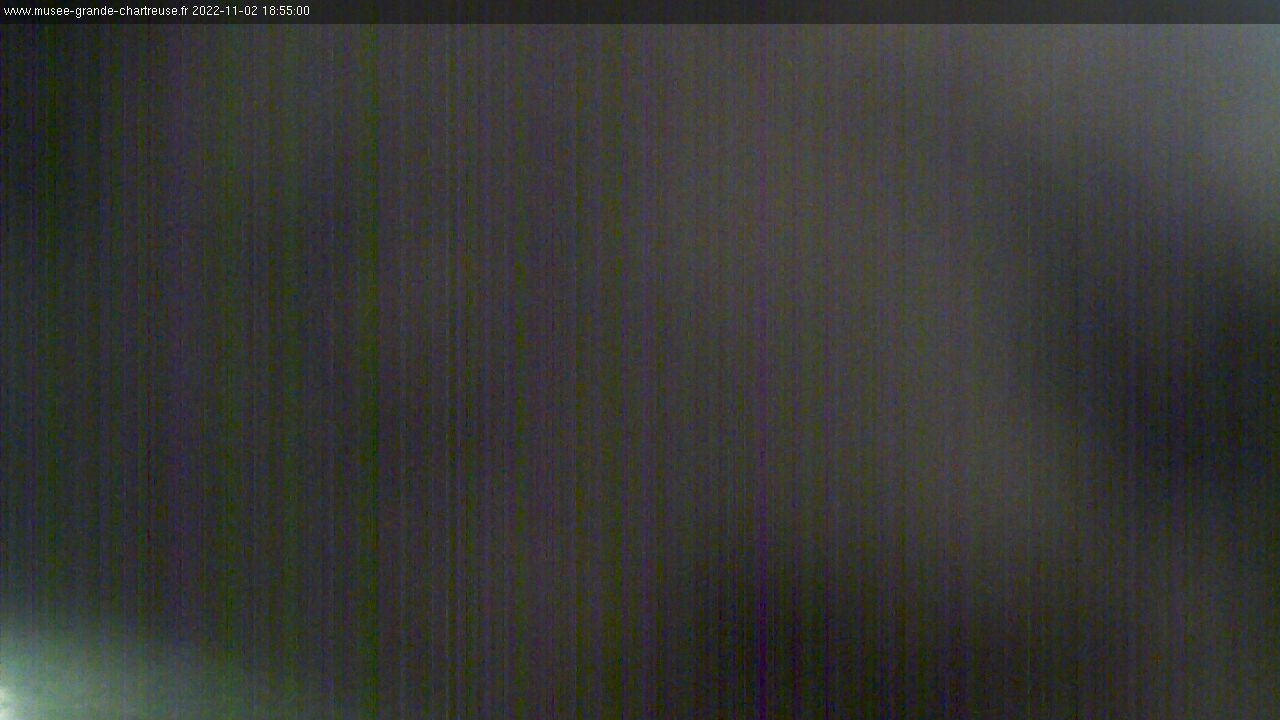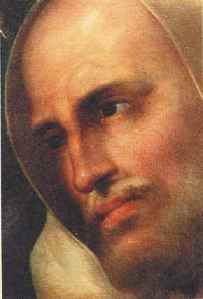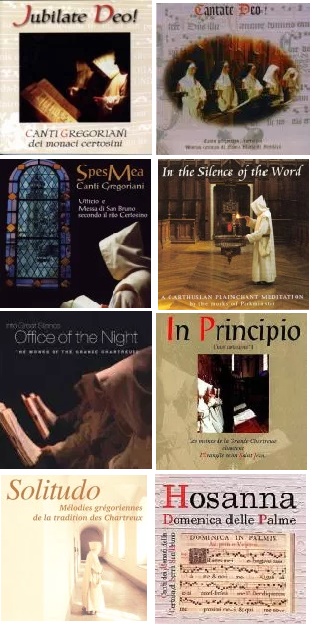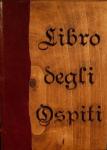Cari amici lettori, eccoci giunti all’ultimo brano tratto per voi dal libro ”Intimidade com Deus” dall’originale francese “Parole de Dieu et vie divine”. In questo ultimo capitolo l’anonimo priore certosino ci parla della vocazione dei certosini. Una spiegazione semplice, ma estremamente esaustiva.
Non è possibile senza l’aiuto della grazia speciale cercare di definire lo spirito di uno dei grandi Ordini della Chiesa, i cui interessi sono in realtà gli interessi di Dio, in modo che nessun uomo sia in grado di parlarne, è ancora più difficile quando questo Ordine è contemplativo, fedele per nove secoli alla sua stretta clausura: la sua vita segreta, per rivelarsi, ha bisogno di una cordialità e di una risposta interiore. Ma per parlare della vocazione certosina, sarebbe necessario, soprattutto, averlo seguito alla perfezione: e si vergogna di aver fatto così poco che abbiamo scritto queste righe.
Non importa quanto vogliamo esprimere l’intenzione che anima la vita dei certosini e dei loro religiosi, dobbiamo farlo nei termini più semplici. Le nostre anime sono le mogli di Gesù Cristo se rispondiamo alla loro chiamata: il nostro ideale è di farlo e vivere solo in unione con Lui. Ci sforziamo di raggiungere questo fine attraverso la vita sacramentale e liturgica, attraverso la preghiera, l’obbedienza, la mortificazione e dall’oblio di noi stessi, nella solitudine e secondo i costumi dell’Ordine Certosino. Sappiamo e sentiamo, per quanto in cui Dio che è disposto a completare questa unione di spiriti e cuori senza indugio, purché rimuoviamo gli ostacoli. Questi ostacoli sono ridotti a uno: attaccamento a noi stessi, che solo l’amore divino può liberarci.
Questa definizione è certamente elementare: molti troveranno strano trovare in essa una dottrina così scarsa e così poche caratteristiche specifiche. Tuttavia, è necessaria questa semplicità: è la prima caratteristica della spiritualità certosina, e ci dispiace dover spiegare queste parole, possiamo aggiungere nulla alla loro sostanza e temiamo per indebolirli con il commento. I monaci e le religiose certosine, impegnati nel servizio di Dio nei loro eremi, non formano una scuola o raggruppati attorno al nome di un maestro, non hanno celebrato autore la cui opera possa fissare le linee del suo sviluppo spirituale e vi darà la strada deve essere imitato da allora in poi. Ma non è solo dalla sobrietà delle formulazioni teoriche che un luogo sembra essere stato riservato per un silenzioso impulso dello spirito; la verginità è una caratteristica essenziale della spiritualità certosina: tutto, in questo Ordine, protegge la vita spontanea dell’anima e la riserva per Dio.
Questo è il senso di solitudine, che osserviamo e che impressiona così gli estranei. Ci abbandoniamo a Dio e solo noi ci sforziamo di vivere. Questa solitudine nel suo aspetto sociale, è inoltre ammorbidito dalla regola: mantenere i rapporti familiari tra di noi, siamo uniti tra loro da una profonda amicizia, come fratelli e sorelle dello stesso ordine. Tuttavia, questi rapporti e questa amicizia solo nel senso che ci può aiutare nella fedeltà alla solitudine, misurandola dalle nostre forze, e la messa alla prova in modo che non perda il suo carattere soprannaturale. Essere soli è, in un certo senso, morire per l’uomo: è per questo che molte volte, dopo averlo provato, alcuni la considerano un’impresa inumana. Tuttavia, l’anima è stata creata per Dio, e ogni altro oggetto chiude il cuore e lo spirito entro i limiti che lo soffocano. Privarla della solitudine, come ora il mondo sembra essere determinato a fare, è renderla una violenza che, più propriamente, può essere chiamata disumanità. La solitudine con Dio è un ideale a cui tendono tutte le anime: il chiostro lo colpisce solo in un movimento più decisivo e diretto. In realtà, non c’è nessun altro compagno che Dio: il cuore che non l’ha ancora scoperto passerà attraverso molte prove e solo in caso di se rimanere leali è che raggiungerà questa prova, non con tristezza rassegnata, ma con profonda gioia.
La vita certosina è anche definita dalla sua attività interiore: questo Ordine è, all’interno della Chiesa, quello che maggiormente si impegna nella contemplazione. Questa parola sembra avere una singolare virtù, che affascina alcuni e inquieti altri. È già stato criticato per il suo uso, che è molto antico: non è vero che ci sono uomini incapaci di ‘vedere’ interiormente ‘contemplando’ qualcosa, non importa quanto zelanti e religiosi possano essere? Dobbiamo rispondere, a nostro avviso, che questa parola è stata scelta in modo provvidenziale per designare l’atteggiamento di una moglie-anima, anche se è lontana dall’essere inondata di luce. Gli spiriti che amano la verità divina la contemplano, e questo atto deve essere l’unico che l’anima benedetta farà in cielo. Ma questo apprendimento sulla terra è fatto nel mezzo della sofferenza e delle tenebre della fede: per questo è un sacrificio, purificazione efficace e insigne testimonianza di carità. Si può contemplare se stessi nelle tribolazioni e nell’aridità, nel lavoro e nella cura del prossimo, e persino nelle tentazioni e distrazioni involontarie, l’unica cosa che conta è che l’anima sia mantenuta rivolta al Signore invisibile e operi secondo con quello sguardo. L’esperienza dell’amore deve farle capire il valore che dà alla contemplazione del suo oggetto, sia nelle tenebre che nella luce, e il puro presentimento della visione che anima la sua fedeltà: infatti, uno è contemplativo in quanto se ti ami – l’unica cosa che conta è che l’anima sia tenuta di fronte al Signore invisibile e operi in base a quello sguardo.
Che questo sforzo possa essere coronato già in questa vita da una perfetta unione con lo Sposo; noi lo crediamo fermamente, perché, in verità, nulla si frappone tra Dio e l’anima. Ma questa unione è, per sua stessa natura, segreta: implica il rispetto per il silenzio in cui lo Spirito lo prepara e lo mantiene.
Il segreto è, inoltre, una delle caratteristiche dell’intera vita cartusiana: monaci e monache vi trovano il fresco rifugio –vita umbratiles– in cui germogliano i fiori eterni. Mentre trascorriamo una parte delle ore notturne nella chiesa, ci sforziamo di santificare attraverso la preghiera il cuore di notte; così la nostra esistenza, lontana dagli sguardi del mondo, imita la vita nascosta del Signore, che visse nel grembo di Maria e durante i trent’anni che prepararono la salvezza del mondo. Abbandonando una società in cui ognuno, ovviamente, cerca di apparire, i certosini i religiosi certosini lottano per scomparire, sperando che la verità accetterà questa prova. Uno dei patroni dell’Ordine, il cui nome è incluso nella nostra formula professione, è Giovanni il Precursore, il profeta solitario che cerca di cancellare fino a brillare agli occhi di tutta la luce della Parola.
Il ruolo delle donne, e in particolare della vergine, come già notato più di una volta, comprende di secolo in secolo una dichiarazione abitabile di pudore: si sente come un velo che protegge queste riserve sacre che devono rimanere pure, affinché le fonti di vita e di bellezza, vale a dire in un senso molto speciale, non possano mai morire sulla terra per le vergini claustrali e consacrate che si coprono di un velo che imita Maria, per custodire e nutrire nella loro vita divina. Ecco perché le nostre monache non sembrano essersi attaccate al nostro Ordine per puro caso, ma per disposizione provvidenziale, in modo che lo spirito di questo stesso Ordine si manifestasse chiaramente nelle sue caratteristiche essenziali e che la nostra risposta ad esso una vocazione per l’incoraggiamento reciproco,
La presenza costante della croce non può essere nascosta in un profilo dell’ideale certosino: abbandonare il mondo è doloroso per il cuore; la solitudine, per quanto preziosa possa essere per se stessa, è un sacrificio quotidiano per la nostra natura peccaminosa; l’obbedienza, la povertà, per quanto saggiamente proporzionata alla forza umana, non può essere accettata e vissuta senza un’agonia di autocommiserazione. Se l’entusiasmo dell’amore non si accende nell’anima scintilla di eroismo, non saranno accettate per un lungo periodo tali compiti sacerdotali certosini o convertire il fratello o la moglie o la madre spirituale. Presuppongono che la chiamata di Cristo sia stata ascoltata: “Se qualcuno mi ama, prendi la sua croce e seguimi”. Non c’è vera vita interiore senza infinita pazienza, e se la vita del convento non è una vita interiore, è una schiavitù singolarmente infelice.
I doni più puri dello Spirito, i doni della fede, dell’intuizione e dell’unione, che sono gioia , hanno tuttavia bisogno di solitudine, silenzio e croce: la loro realtà sfuma in una vita che è troppo comoda, facile. L’isolamento austero e la sofferenza che comporta sono i benvenuti al contemplativo: quando mancano, l’anima è consapevole che perde un prezioso supporto e sarebbe dannoso per lei ad essere privato di esso per un lungo periodo di tempo.
Non ci soffermeremo più su questo aspetto della nostra vita: la vita di bordo è una scuola di pazienza. Esercitato in unione con Cristo, sottomesso al governo e alla fedeltà alla solitudine, la pazienza purifica l’anima, lentamente spende l’amor proprio e ci costringe ad arrenderci a Dio. Il nostro Ministro Generale, Dom Innocenzo Le Masson († 1703), dice che la Certosa è ancora una scuola di carità (nello stile del suo secolo ” un’accademia della carità”): questo punto è, infatti, il centro di la nostra comunità religiosa, il suo inizio e la sua fine. I sacrifici di cui abbiamo appena parlato, l’abbandono e la rinuncia, hanno come unica ragione per essere la carità che manifestano, come affermato nei nostri Statuti.
L’unica cosa che si fa nei nostri monasteri è amare Cristo con tutta la nostra forza: noi sappiamo che l’abbondanza di questo divino amore ci verrà data se siamo fedeli, e diffusa su tutte le anime che ne hanno bisogno. Non c’è un solo certosino che non si consideri un missionario in questo senso; non c’è una vergine certosina che non abbia il sentimento della sua maternità spirituale e non possa dire con Cristo: “Lo Spirito del Signore si è posato su di me; perché egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire i contriti di cuore, proclamare ai prigionieri la redenzione, e alla vista ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno favorevole del Signore, e il giorno di retribuzione “(Luca, IV, 18-19).
L’ufficio divino e il canto corale sono l’espressione dell’amore che la Chiesa, la Sposa di Cristo, mette nelle nostre bocche, affidandoci ufficialmente le loro dichiarazioni, i loro giuramenti e le loro lodi. La carità che deve essere la vita del chiostro si manifesta invece tra i membri dello stesso monastero sia con uno sforzo continuo di delicatezza e comprensione, sia con la comunione dei cuori saziati nella stessa fonte. Questo ideale non è sempre raggiunto nella sua perfezione, ma è realizzato in modo più coerente dei giudici del mondo, e la sobria fratellanza monastica dell’espressione, nutrita dal silenzio, è un prezioso rifugio per l’anima nel suo pellegrinaggio interiore.
Spesso ci sembra che le persone del secolo tra le quali parliamo di amore e amicizia possano beneficiare dell’esperienza delle nostre comunità: infatti, nessun affetto può resistere se non è garantito da una volontà quotidiana e dalla pratica della rinuncia, ciò ti consente di affrontare tutte le difficoltà con buona volontà; nessun amore può vivere se non è pronto a sacrificare anche alle sue stesse gioie. Coloro che non riconoscono queste verità non sanno amare come amano i certosini e non crediamo che possano amare altrove.
Dom Le Masson, che rende la certosa “un’accademia di beneficenza”, vede anche in lei ciò che può sembrare ancora più strano – “un’accademia di libertà”. È sufficiente, tuttavia, avere l’esperienza di un novizio certosino per sapere che la prima impressione è quella che viene ridotta nel Salmo CXXIII: Laquens contritres est et nos liberati sumus”Il circuito era rotto e noi eravamo liberi.” Lo spazio interiore è invero infinitamente più vasto di quello che ci circonda: ciò che tiene prigioniero un uomo è l’amore avido di beni transitori, l’ambizione ristretta, la preoccupazione paralizzante di ciò che gli uomini possono dire o pensare di noi, – in una parola, l’amore di sé in tutti i suoi aspetti. La sincera risoluzione di porre fine alle sue richieste, di trattarci con saggio disprezzo, con giusta ironia, è paragonabile a sollevare un peso sotto il quale potrebbe a malapena battere il cuore. I voti non fanno altro che rompere gli ormeggi. La via della libertà non è quella dei successi esterni: al contrario, scende anche al più segreto dell’anima, al terreno divino in cui lo Spirito attento alla verità ci rende liberi (Giovanni, VIII, 32). Questa libertà si sviluppa, è come una scoperta sempre nuova man mano che l’intimità con Dio cresce, riconosce la sua presenza immediata e gli permette di viverla.
Dio è più gentile di quanto si pensi e più facile da sapere di quanto si pensi. Amandolo e conoscendolo sono due grazie strettamente correlate: nessun progresso è fatto nell’amore che non renda la certezza su cui poggiano l’equilibrio e il volo dello spirito. Amare e contemplare nella solitudine caritativa porta l’anima a dimenticare sempre più se stessa finché la trasparenza dello specchio interiore permette a Dio di riprodursi e di riposare in esso completamente. Allora si adempirà il grande comandamento: “Date a Dio ciò che è di Dio”, questo è tutto. Le domande e le risposte sono basate su un singolo brano di lode, l’unione è consumata in silenzio al di là delle nostre misure; la moglie appartiene al marito: la libertà è stata vinta.
Che lo Spirito sia ascoltato meglio!
Possano cuori generosi seguire Gesù senza paura del deserto!
E che coloro che hanno osato fare questo schema dell’ideale certosino, aiutati dalle preghiere dei loro lettori, possano viverlo in modo più fedele, per la loro salvezza e per tutte le anime. Venite et bibite, amici: inebriamini, carissimi! “Vieni, amico e bevi alla sorgente, ubriacati, amico mio!”(Canzone V, 1).
Filed under: Testi | Tagged: certosini, Intimidade com Deus, meditazione, spiritualità, testo spirituale | Leave a comment »