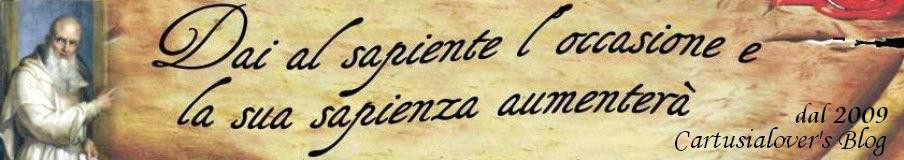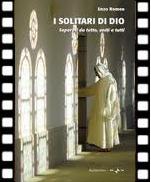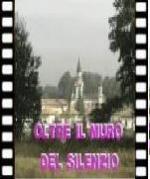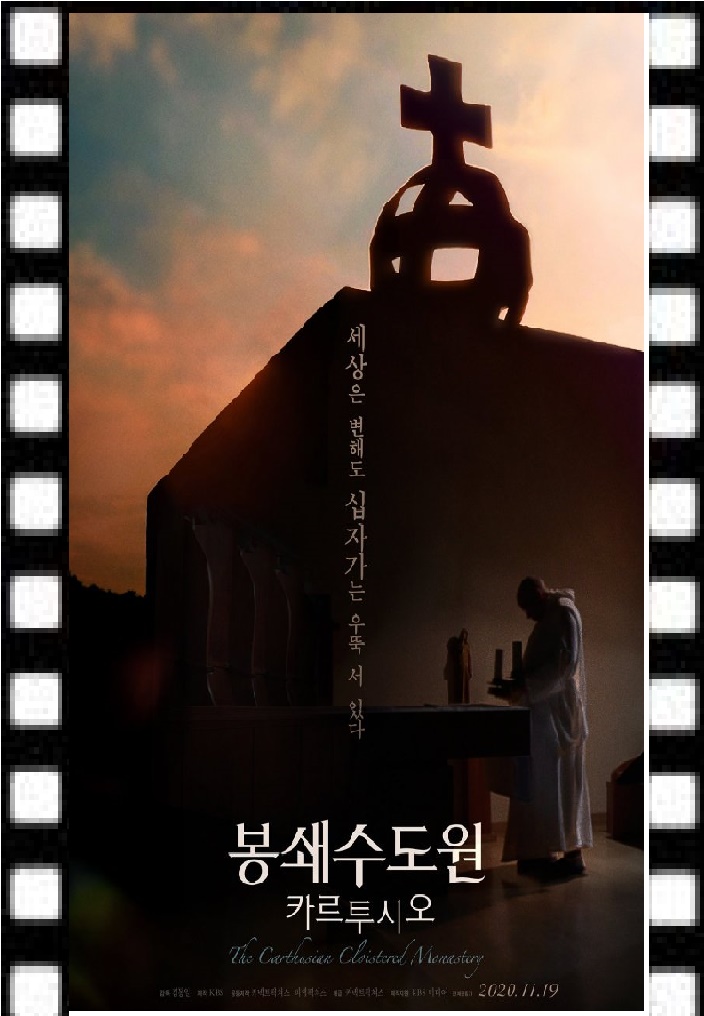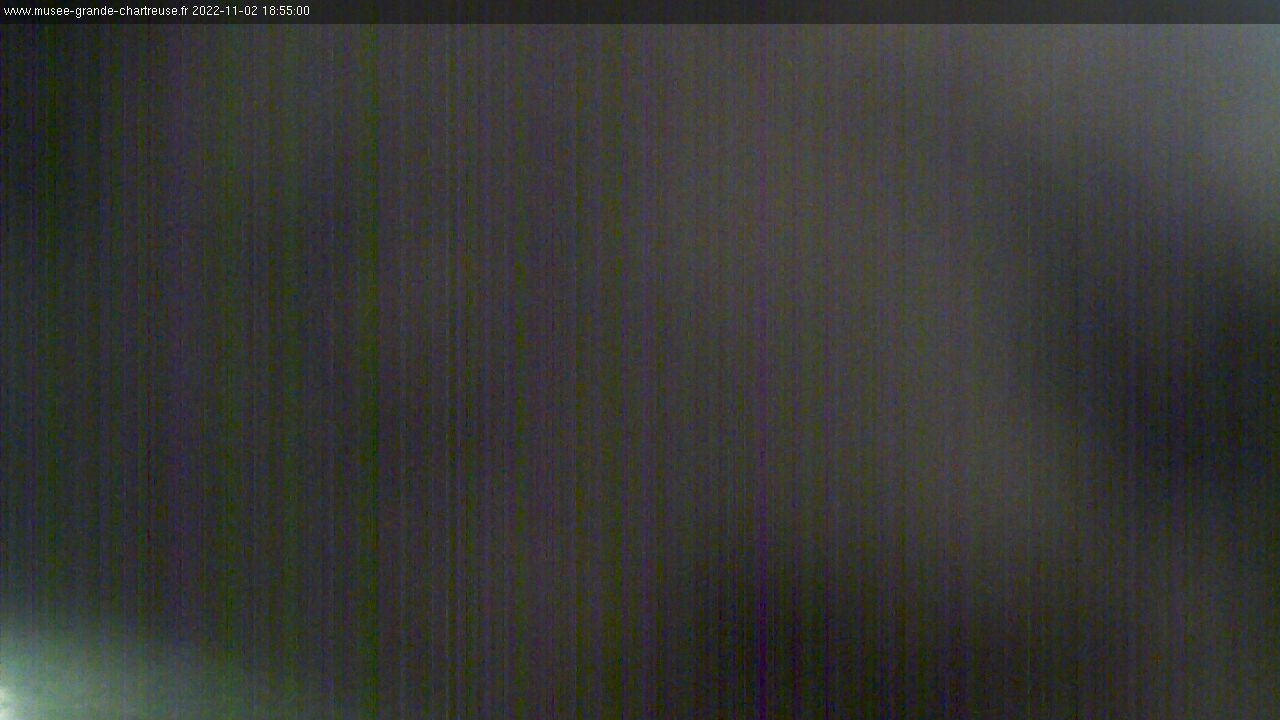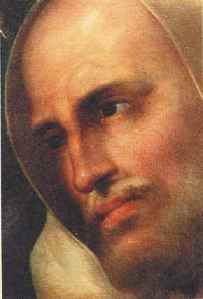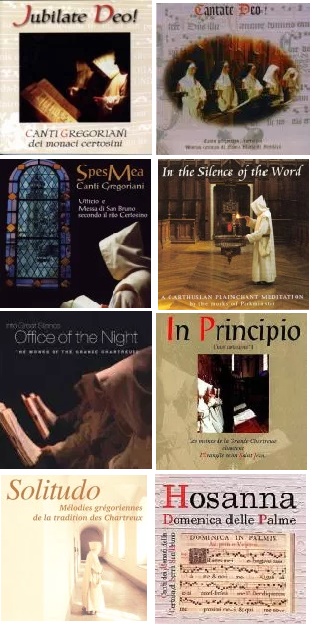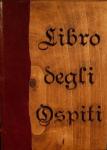Cari amici lettori, nell’articolo odierno voglio comunicarvi la pubblicazione di un’importantissimo volume, del quale vi riporto la brillante recensione dell’amica Giuliana Marcolini, giù coautrice di un libro di cui vi ho parlato da questo blog.
L’Autore di questo importante, impegnativo e specialistico lavoro è un monaco certosino che, secondo la consuetudine dell’Ordine, rimane nell’anonimato; l’argomento trattato, come si evince dal titolo, è l’edizione delle Carte prodotte dal Capitolo generale dell’Ordine certosino relative alla Provincia Tusciae dal 1701 al 1730; note anche come “Carte di Ferrara” o “Carte di Toscana”, sono conservate negli archivi della Grande Chartreuse, la casa madre dell’Ordine, situata a Saint-Pierre-de-Chartreuse, nei pressi di Grenoble.
Queste Chartae sono parte dell’intera documentazione prodotta durante le riunioni del Capitolo Generale, organo legislativo ed esecutivo supremo dell’Ordine certosino, indetto inizialmente ogni anno, ora ogni due, presso la Grande Chartreuse di Grenoble, e operante fin dal 1142. La pubblicazione delle Carte dei Capitoli Generali, a partire da quelle prodotte in epoca medievale era iniziata nel 1982 per volontà del grande studioso e grande esperto, anche per esperienza personale, del mondo certosino quale fu James Hogg, che le aveva inserite nella collana Analecta Cartusiana. Questa collana, l’unica raccolta internazionale di scritti dedicati alla storia e alla spiritualità dei certosini, era stata fondata dallo stesso Hogg nel 1970 e poi, dopo la sua morte nel 2018 e per volontà degli eredi, è entrata a far parte delle collezioni editoriali di carattere religioso di CERCOR (Centre européen de recerche sur les communautés, congrégations et ordres religieux); con l’acquisizione di questa collana, CERCOR è divenuto il polo europeo delle pubblicazioni relative al mondo certosino.
Tutte le pubblicazioni riguardanti l’edizione delle Chartae Capitulorum Generalium sono contrassegnate dal numero 100 di «Analecta Cartusiana» ed il volume qui recensito è il 76° della serie.
Il testo di questa pubblicazione consta di 515 pagine, articolato in più parti:
– Prefazione, pp. 3-14:
L’autore della Prefazione, Giovanni Malpelo, scrive che, partendo dal presupposto che ogni carta d’archivio è uno spiraglio privilegiato da cui gettare uno sguardo verso la Storia, e sottolineando in particolare l’importanza degli archivi ecclesiastici per comprendere i rapporti tra Stati e Chiesa nei vari momenti storici, afferma che la trascrizione delle Chartae Capituli Generalis pro Provincia Tusciae certosina ci offre una lettura che va oltre la conoscenza della vita nelle certose italiane comprese in tale circoscrizione geografica durante il secolo XVIII, ma ci fa intravedere come l’Ordine si sia posto in relazione con lo spirito dell’epoca; epoca che la storiografia odierna vede contrassegnata dal termine “rivoluzione”, identificabile in molti campi, da quello politico a quello industriale fino a quello culturale, e che ha dato inizio alla “modernità”.
Anche i Certosini, pur nella loro beata solitudo, avendo chiaramente percepito che al di fuori del loro desertum vi era allora un mondo che andava mutando rapidamente avevano scelto di inserire nello stemma dell’Ordine Certosino, o meglio, in quello della Grande Chartreuse, la Casa madre, il motto Stat crux dum volvitur orbis: la terra si muove, si agita, muta, si ‘rivoluziona’ ma la croce di Cristo è la realtà immobile e immutabile cui ogni certosino di ogni certosa aspira ad identificarsi.
Questa aspirazione alla fedeltà alla più grande espressione della religiosità cattolica ed alla volontà di mantenerla immutata nel tempo universalmente in ogni certosa in qualunque situazione geografica e politica prende forma tangibile nelle Chartae Capituli Generalis, le cui pagine riportano fatti, notizie, disposizioni che si rivolgono in modo immutato nel tempo e universale nella territorialità del mondo certosino. Come esempio concretamente esplicativo Malpelo ci segnala che nelle Chartae di tutti i Capitoli generali “si fa memoria e si menzionano i fratelli defunti nell’anno di qualsiasi certosa di provenienza presente nel mondo (i cosiddetti obiit). Quest’abbraccio universale si ripete poi quasi in ogni parte delle Chartae”.
– Introduzione, pp. 15-58:
L’Autore (un monaco certosino) ci ricorda che le Chartae Capitulorum Generalium contengono i suffragi per i vivi e per i morti che le singole Case dovevano assolvere, le disposizioni sui cambiamenti di ufficio e le ordinanze con valore di legge emanate per tutto l’Ordine o per gruppi di monasteri. Pur di “un’appassionante monotonia”, data una struttura monolitica ed invariata nella forma espressiva ed un testo costituito da frasi stereotipate e ripetute, la lettura di queste Carte ci fa ‘intravedere’ come, nel corso del tempo e dei momenti storici, quel ‘mondo’ che i singoli monaci pensavano di aver abbandonato, in realtà sia penetrato nella trama della loro quotidianità. I grandi problemi che scuotevano l’Europa e le prospettive generali della Christianitas nei confronti degli Stati riuscivano a penetrare la clausura certosina e questo è chiaramente visibile attraverso i numerosi suffragi per singoli e comunità estranee al mondo certosino che i monaci erano tenuti ad assolvere. Questo, però, è chiaramente leggibile solo nelle Carte più antiche; l’Autore ci propone una tavola sinottica (vedi nel testo pp. 24-26) in cui vengono messi a confronto gli “obblighi” di suffragi in epoca medievale e quelli del XVIII secolo e si può notare come in questi ultimi scompaiono dal primo posto gli obblighi di suffragi per “Principi e sacerdoti secolari”, e compaiono quasi al termine dell’elenco. Chiaro sintomo del fatto che i Certosini, in questo secolo di grandi ‘rivoluzioni’, hanno sentito la necessità di rafforzare il loro ‘distacco’ della loro realtà dal mondo esterno.
L’intero corpus delle Chartae Provinciae Tusciae consta di nove tomi manoscritti in lingua latina, composti da fascicoli di varie dimensioni, che contengono carte o estratti di carte relative ai ‘verbali’ redatti durante i Capitoli generali tenutisi alla Grande Chartreuse dal 1462 al 1796, contenenti le relazioni dei visitatori delle varie certose della Provincia Tusciae con le notizie specifiche di ogni certosa e le eventuali decisioni prese in seno al Capitolo sia riguardo ad una specifica certosa sia riguardo a disposizioni di carattere normativo generale; le copie di questi verbali, dopo il Capitolo, venivano consegnate ai Visitatori che le portavano poi ai vari priori delle singole certose della Provincia.
Benché già note da tempo nella letteratura specializzata certosina, le Chartae Provinciae Tusciae, conservate negli archivi della Grande Chartreuse in nove volumi (Ms 1 Cart 24), non sono state finora oggetto di studio particolareggiato.
La consultazione diretta della serie ne ha rilevato l’importanza per la storia dell’Ordine certosino e per la conoscenza del suo sviluppo in quelle regioni dell’Italia centro-settentrionale, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, che costituivano il territorio della storica Provincia Tusciae; da qui la decisione di progettare una pubblicazione della trascrizione di tutti i volumi manoscritti di dette Chartae nella collana «Analecta Cartusiana», cominciando dalle Carte del XVIII secolo, cioè i volumi 7-9 (con documentazione dal 1701 al 1789) dato che i primi sei (con documentazione dal 1462 al 1700) sono attualmente in fase di restauro e si potrà procedere alla loro trascrizione e pubblicazione al termine dell’operazione, in ragione di un tomo a stampa per ogni volume manoscritto, rendendoli così facilmente disponibili all’approfondimento degli studiosi della ‘certosinità’.
– Trascrizione delle “Chartae Capituli Generalis pro Provincia Tusciae ab anno 1701 usque ad annum 1730 (manoscritto Grande Chartreuse 1 Cart 24 Volume 7) (pp- 59-438)
La trascrizione del volume manoscritto 7 delle Chartae Capituli Generalis pro Provincia Tuscia occupa la quasi totalità dell’intero testo in recensione; il volume contiene le carte di 30 Capitoli Generali tenutisi annualmente dal 1701 al 1730 ed è formato da 30 fascicoli composti ognuno di un numero di carte scritte variabile.
Anche il testo di queste carte, come quello di tutte quelle prodotte durante ogni Capitolo generale, era impostato prima della riunione generale in Grande Chartreuse. I fascicoli erano composti da 6 fogli in 4°, piegati al centro (12 carte); sul primo recto veniva scritto il nome della provincia (Provincia Tusciae, Provincia Sancti Brunonis, Provincia Picardiae, ecc.) cui il documento era indirizzato. Si preparavano poi i dati generali e sempre fissi fin dal primo Capitolo: il titolo e la data del Capitolo generale, la data della Settuagesima, la lista delle SS. Messe dello Spirito Santo e della Beata Vergine per varie intenzioni e la parte finale del documento con le generalità, e le disposizioni per le singole certose. I defunti (per i quali quella certa certosa aveva l’impegno di celebrare i suffragi) il cui obitus era già pervenuto alla Gran Certosa erano trascritti secondo l’ordine che si era codificato nel XVIII secolo, che vedeva in primis i visitatori, seguiti dai convisitatatori, dai monaci semplici, dai monaci diaconi, dai conversi, e, nel caso di un monastero femminile, dalle monache certosine, poi veniva l’elenco dei sacerdoti secolari, i secolari e per ultime le Donne. Ricordiamo che nelle carte più antiche, l’elenco dei defunti vedeva come prima voce i principi e i sacerdoti secolari, seguiti dai priori e monaci certosini (si veda nel testo la esplicativa tabella sinottica della situazione alle pp. 24-26).
È da rilevare che in questo volume 7 le Carte prodotte dal Capitolo generale dal 1715 al 1724 furono affidate a Dom Daniele Campanini, priore della certosa di Ferrara dal 1703 al 1725, convisitatore della Provincia Tusciae dal 1715 al 1720 e visitatore della stessa dal 1721 al 1725 e che in questi periodi fu presente ai vari Capitoli tenutisi nella Grande Certosa, perché le portasse alle certose della Provincia Tusciae; personaggio di grande spessore religioso e culturale, dom Campanini era già stato priore della Casa ferrarese dal 1692 al 1698 e fu committente per la sua Casa di varie importanti opere d’arte celebrative della ‘certosinità’.
A seguito della trascrizione di tutte le Carte del volume 7, l’Autore ha predisposto otto Appendici (pp. 439-496), con notizie ricavate da varie fonti di carattere certosino, utili per agevolare la consultazione del testo stesso e fornire molti dati ed informazioni inediti di particolare interesse per l’approfondimento della storia dell’ordine nel XVIII secolo:
Appendice I. Elenco dei fascicoli dei volumi 7, 8 e 9 delle Chartae Tusciae
Appendice II. Liste dei Priori della Provincia Tusciae secolo XVIII (fino alle soppressioni)
Appendice III. Lista dei Visitatori e Convisitatori della Provincia Tusciae secolo XVIII
Appendice IV. Lista dei Reverendi Padri, Priori della Gran Certosa XVIII secolo (fino alle soppressioni (tratta da La Grande Chartreuse per un charteux, Bellegarde 1984, pp. 292-293)
Appendice V. Lista dei Vicari della Gran Certosa XVIII (desunta dalle Chartae Provincia Tusciae)
Appendice VI. Elenco delle Ordinanze, Ammonizioni ed Esortazioni promulgate dai Capitoli Generali nel secolo XVIII, desunte dalle Chartae Provincia Tusciae
Appendice VII. Le Case della Provincia Tusciae (da Monasticon Cartusiense, IV, 4: Provincia Tusciae, «Analecta Cartusiana» 185/4/4, 2010)
Appendice VIII. Trascrizione del Manoscritto Grande Chartreuse 6/ITAL/11.
A corredo dell’intera pubblicazione si segnala una significativa e ricca Bibliografia, di riferimento (pp. 13-14) e specialistica (pp. 50- 58).
I documenti d’archivio sono lo strumento oggettivamente più efficace per la conoscenza e l’interpretazione della ‘storia’ di qualunque realtà che lo studioso attento e ‘curioso’ utilizza con particolare entusiasmo. Ma non sempre è possibile la consultazione diretta delle fonti, come nel caso della documentazione prodotta dall’Ordine Certosino che, nel suo eremitismo estremo, precludeva e preclude il contatto fisico diretto con le sue realtà; ecco che allora iniziative editoriali come quella che ha preso l’avvio con l’esperienza di «Analecta Cartusiana», di cui questo volume è un significativo esempio, sono preziosissimi strumenti per la conoscenza e l’interpretazione del mondo certosino.
Attraverso queste pubblicazioni riusciamo, infatti, a percepire quanto il mondo certosino non fosse così ‘impermeabile’ alla realtà esterna alle sue mura quanto si poteva ritenere e nel contempo, ci rendono possibile entrare in un mondo a noi totalmente precluso, conoscerne la sua struttura e le sue modalità di perpetuazione e mantenimento nel tempo di quella ideologia religiosa che ne determinò la nascita.
Giuliana Marcolini

Nell’esprimere gratitudine all’amica Giuliana Marcolini, la quale ha redatto tale recensione che ho voluto ospitare su Cartusialover al fine di renderne nota tale pubblicazione e diffonderla a voi tutti.
Vi inoltro il link dove poter acquistare online questo prezioso volume, disponibile all’approfondimento di chiunque voglia studiare gli argomenti in esso illustrati.
Filed under: News, Testi | Tagged: approfondimento, certosini, Chartae Capituli Generalis Pro Provincia Tusciae, Provincia Tusciae, studio, testo, un certosino, volume | 1 Comment »